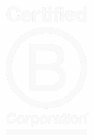Avere un tavolo al Tatiana by Kwame Onwuachi è ormai un trofeo gastronomico. Situato nel cuore del Lincoln Center, il ristorante è diventato simbolo della nuova New York post-pandemica: consapevole, colta, identitaria. Merito di uno chef carismatico che ha fatto della cucina afro-caraibica una dichiarazione culturale potente, orgogliosamente radicata nel suo vissuto familiare e nella storia della diaspora nera americana.
Non si viene al Tatiana solo per cenare: si viene per ascoltare un racconto fatto di ingredienti, spezie, memoria. Ma se ci si arriva da soli, e magari con un gusto europeo, l’impatto può essere straniante. Io ci sono riuscita (lo volevo assolutamente provare e ho usato il trucco di arrivare molto prima dell’apertura delle 5 pm, essere una delle prime in fila fuori, e riuscire prendere uno dei sei posti al bar) e ho ordinato liberamente dal menu.
La cucina è intensa. Tutto è marinato in spezie e zucchero, e poi o fritto o stufato e glassato senza risparmio di grassi. Il gusto è ovviamente buonissimo, pieno, rotondo, dolce e grasso. Un’esplosione di comfort food, senza esitazioni, ma anche senza leggerezza. I piatti sono tutti pensati per la condivisione, in porzioni generose (“small” e “large share”) senza possibilità di mezze porzioni, quindi da sola è stata molto dura assaggiare più di una cosa senza sentirmi sopraffatta.
Ma la sorpresa più grande per me non è venuta dal palato, bensì dalla tavola. Da architetto e fondatrice di Raremood, osservo sempre la mise en place con grande attenzione: piatti, materiali, textures. Ecco, qui il mio sguardo è rimasto un po’ a bocca asciutta. L’impiattamento è allegro, ironico, supercolorato, volutamente anti-minimalista, ma la cura per le stoviglie e le ceramiche è quasi assente. Nessun oggetto racconta qualcosa in sé, e la mise en place nel complesso è “easy”, a tratti distratta – un peccato, considerando che il racconto visivo del cibo può essere potente quanto quello gustativo.
È comunque un’esperienza da fare. Perché per quanto potente sia il racconto gastronomico, l’approccio resta quello del comfort food americano: eccessivo, calorico, quasi mai salutare. Un dato culturale che va al di là del singolo ristorante: ancora oggi anche nella pubblicità televisiva americana, il cibo più rappresentato è quello da fast food, da strada, conditissimo, filante, avvolgente. Un’estetica dell’abbondanza, che risponde ancora a un bisogno molto profondo di protezione e appagamento immediato, che non pensavo fosse ancora così radicato in USA.
L’ascesa della cucina “povera” afroamericana, oggi finalmente celebrata anche dall’alta ristorazione, è un fenomeno positivo, sia per motivi storici che identitari. Ma resta il fatto che la cultura alimentare americana sembra avere ancora un rapporto complicato con la salute, con la sobrietà, con l’equilibrio e il principio di sottrazione.
Tatiana è il racconto autentico e affascinante di una memoria collettiva, ma rappresenta davvero la New York di oggi? O forse la sua nostalgia? Non è un luogo per chi cerca una cucina elegante, bilanciata, o semplicemente più vicina ad una sensibilità contemporanea. L’ho vissuto come un viaggio nel passato e in un altro modo di mangiare. Di vivere. E di raccontare se stessi attraverso il cibo.
In conclusione: da provare? Assolutamente si. Ma anche solo una volta può bastare.
Photo credits: www.tatiananyc.com